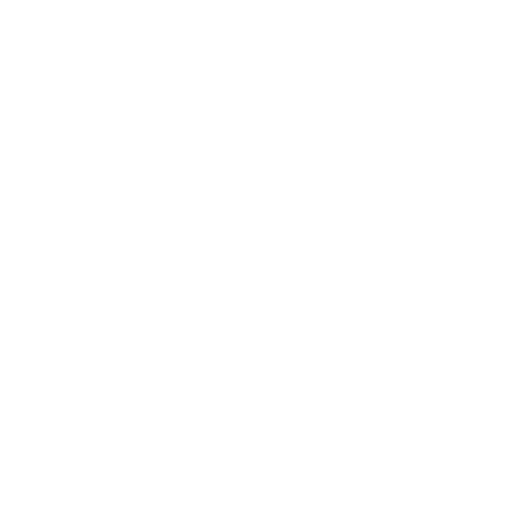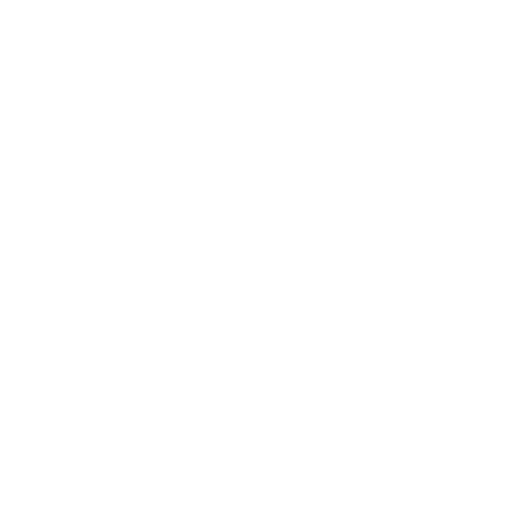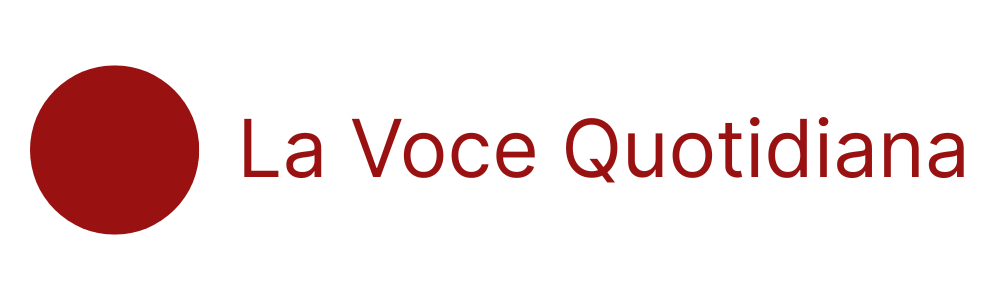di Luca Baraldi

Il 18 gennaio 2025, la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Osama Elmasry Njeem, noto come Osama Almasri, sulla base di accuse di gravi crimini di guerra e contro l’umanità, commessi a partire dal 2015, nella prigione di Mitiga, nei pressi di Tripoli. Il 19 gennaio, Almasri è stato arrestato dalla DIGOS a Torino, mentre assisteva a una partita di calcio. Il 21 gennaio, tuttavia, la Corte d’Appello di Roma ha disposto la sua scarcerazione, dichiarando illegittimo l’arresto, per la mancata autorizzazione da parte del Ministro della Giustizia, come previsto dalla legge n. 237/2012 che disciplina le modalità di cooperazione tra l’Italia e la CPI. Successivamente, Almasri è stato rimpatriato in Libia con un volo di Stato italiano, in un contesto di azioni apparentemente non coordinate tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, che sollevano dubbi sull’aderenza dell’Italia agli obblighi internazionali e sulle possibili motivazioni politiche della decisione, legate alle relazioni bilaterali con la Libia.
Il contenuto del mandato d’arresto e la scelta della declassificazione
Il mandato d’arresto della CPI accusa Almasri di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, tra cui omicidi, torture, stupri, violenze sessuali, trattamenti crudeli e persecuzioni. Tali crimini sarebbero stati perpetrati nella prigione di Mitiga, dove Almasri, in qualità di responsabile delle strutture carcerarie, avrebbe ordinato o commesso direttamente atti contro detenuti, molti dei quali imprigionati per motivi religiosi o ideologici.
A seguito della scarcerazione e del successivo rimpatrio di Almasri, la CPI ha deciso di declassificare il mandato d’arresto, originariamente emesso sotto sigillo ma oggi facilmente consultabile (con il numero di registrazione ICC-01/11-149-US-Exp). La scelta di rendere pubblico il documento è stata motivata dalla volontà di garantire la massima trasparenza e dalla necessità di sollecitare una piena cooperazione da parte degli Stati membri, come previsto dallo Statuto di Roma, permettendo al contempo di evidenziare la gravità delle accuse.
Il dibattito
La gestione del caso Almasri ha scatenato un acceso dibattito, in Italia e sulla scena internazionale. L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha criticato duramente il Governo per aver permesso la liberazione e il rimpatrio dell’accusato, sottolineando il rischio di compromissione della credibilità internazionale dell’Italia. Anche l’opposizione ha contestato la vicenda, con richieste di chiarimenti urgenti al governo Meloni e accuse di decisioni guidate da logiche politiche, anziché da considerazioni giuridiche.
Tra le critiche principali emerge l’interpretazione restrittiva della legge n. 237/2012, che assegna al solo Ministro della Giustizia il compito di gestire le richieste pervenute da parte della CPI. Tuttavia, molti esperti hanno sottolineato che, in casi di urgenza, sarebbe possibile applicare norme generali del Codice di Procedura Penale, per autorizzare un arresto provvisorio, in attesa di ulteriori accertamenti o verifiche. La scelta di rimpatriare Almasri ha inoltre sollevato sospetti relativamente ad un possibile compromesso politico, legato alla cooperazione tra Italia e Libia, soprattutto in tema di controllo e gestione preventiva dei flussi migratori.
Le questioni aperte
Il caso Almasri solleva interrogativi profondi sul rapporto tra diritto interno e obblighi internazionali. Come conciliare il legittimo esercizio della sovranità nazionale e l’impegno a garantire giustizia per crimini internazionali? Quali possono essere le implicazioni per la credibilità dell’Italia nell’aderire a organismi internazionali come la CPI? In che misura considerazioni di carattere politico devono poter influenzare decisioni riguardanti accuse di questa gravità? Queste domande rimangono al centro di una vicenda che mette alla prova la coerenza e l’efficacia dell’Italia nel rispettare i suoi impegni sul piano internazionale. Forse, in un quadro più ampio di trasformazioni della scena globale, richiedono una rinnovata riflessione sulla volontà e la capacità degli Stati di perseguire obiettivi più estesi degli immediati interessi nazionali.
6 Marzo, @Marco da Redazione 365Press