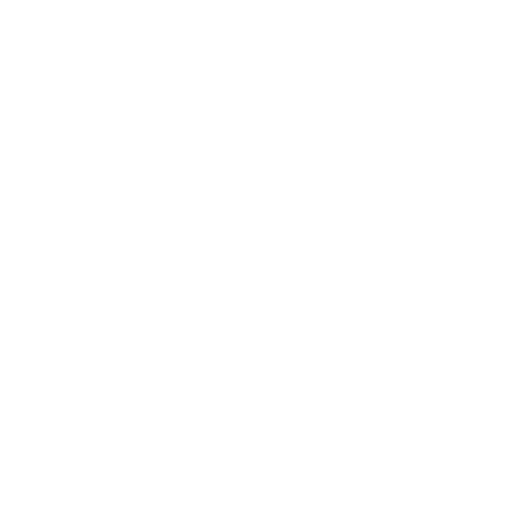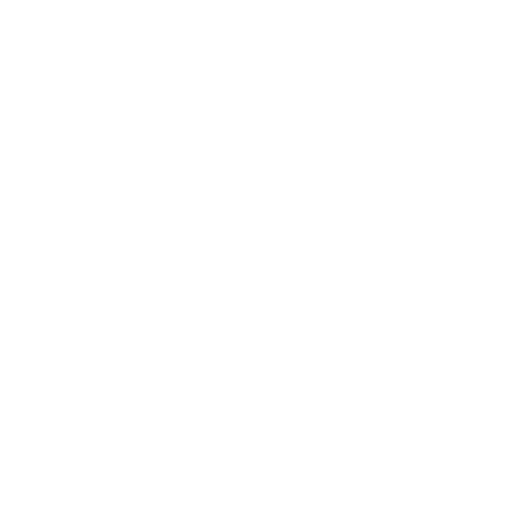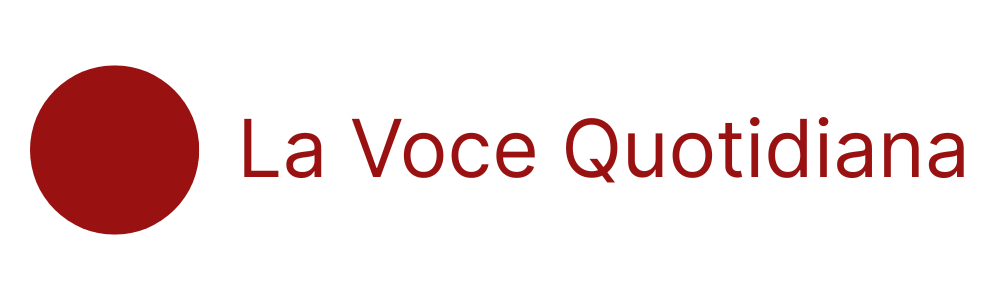La nuova Amministrazione statunitense ha spinto l’UE a ripensare ai propri strumenti e piani di difesa. Stefano Cont, direttore Capability, Armament and Planning dell’European Defence Agency, spiega qual è la situazione e quali le priorità
Ci sono voluti poche ore per rendersi coniare il termine “tsunami Trump” in Europa, dove le decisioni della nuova Amministrazione hanno costretto a un ripensamento non solo dei propri rapporti con l’altra sponda atlantica, ma degli assetti della difesa della stessa Ue. I 27 hanno dovuto fare i conti con la constatazione che nell’immediato futuro (e nel presente) dovranno fare a meno dell’ombrello statunitense. Il che non significa soltanto trovare una nuova protezione – magari nucleare e magari fornita dalla Francia come proposto dal Presidente Emmanuel Macron – ma a una nuova visione sugli investimenti in termini di armamenti e dispositivi di difesa. D’altro canto i dati parlano chiaro: come scrive Janan Ganesh sul Financial Times, l’Europa ha il 7% della popolazione mondiale, produce circa il 20% del Pil, gode del 50% dello stato sociale del mondo, ma ha una spesa di difesa minima. Per questo il sinologo Francesco Sisci, ha esortato a un cambio di rotta: «La spesa per la difesa è questione esistenziale, di vita o di morte, per l’Europa”.
D’accordo anche Stefano Cont, direttore Capability, Armament and Planning dell’European Defence Agency-EDA. Nel presentare il piano ReArm Europe, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha esortato a «reagire con la rapidità necessaria». Parole di fronte alle quali Cont, intervistato da Bruxelles da Atlantis, osserva: «Indubbiamente c’è stata un’accelerazione e occorre investire di più in difesa per due motivi: lo richiede la situazione internazionale, che necessita di spalle più larghe in termini di capacità militari; ma va anche recuperato il periodo di under-investment nel settore della difesa, insufficiente. Oggi serve colmare il deficit di capacità perché in passato non abbiamo speso quanto dovevamo. La frammentazione tra i 27 Stati membri, inoltre, non permette un’economia di scala che invece consentirebbe acquisti a costi inferiori. Basti pensare che, come riporta annualmente il Defence Data, nel 2023, i 27 Stati membri dell’UE hanno speso complessivamente un record di 279 miliardi di euro, circa 302 miliardi di dollari. la spesa militare degli Usa è di circa 850 miliardi di euro, contro i 968 miliardi di dollari degli USA, riferiti da The Military Balance+. Ma oltre al divario economico, occorre tener presente che l’Ue non conta su un terzo di capacità operativa. C’è molto da lavorare».
Ma in che direzione e in che tempi? «È da vent’anni che l’Agenzia europea per la Difesa ci lavora. Ma finora i trattati prevedevano che questo campo d’azione rimanesse di competenza e sotto la responsabilità dei singoli Stati membri – spiega Cont – Gli accordi europei, come il trattato di Lisbona, hanno permesso di sviluppare piani di cosiddetta “common security” e “defence policy”, all’interno del quale è stato creato uno spazio e un ruolo specifico per l’EDA. Ma finora il tema della difesa non è stato centrale come altri, come ad esempio l’economica. L’approccio che fu scelto per la difesa, così come per la NATO del resto, è stato intergovernativo: l’obiettivo, dunque, era di sviluppare strumenti per la collaborazione tra gli Stati membri». Non, dunque, una vera e propria difesa comune paragonabile a quella statunitense, con una struttura federale centrale.
«Il secondo fattore che ha caratterizzato l’azione europea finora è di tipo storico: negli ultimi 30 anni, all’incirca dalla caduta del muro di Berlino, e fino a 5/10 anni fa, parlare di difesa militare non è stata una priorità. Non essendoci minaccia concreta, strutturata, reale e pressante, le operazioni comuni erano costituite soprattutto da missioni di pace, ricostruzione e stabilizzazione, dunque nell’alveo degli interventi di peace keeping, con una forte componente civile oltreché militare. L’esigenza era non solo e non tanto di avere una forza deterrente sul terreno, ma di favorire un percorso di pace. Oggi, invece, si avverte la necessità di poter affrontare attività ad alta intensità, con una dimensione militare superiore e una maggiore integrazione tra gli Stati membri», spiega ancora il Direttore.
«Di fronte al cambio di situazione, dunque, si lavora per indagare la possibilità di operazioni di sicurezza complesse, ad alta intensità e protratte nel tempo, come del resto già previsto nello “stategic compass”», osserva Cont, riferendosi alla Bussola strategica per la sicurezza e la difesa, ossia il piano d’azione europeo che contiene la strategia e gli obiettivi concreti per rafforzare la politica di sicurezza e di difesa dell’UE.
Un aspetto non di poco conto, però, è rappresentato dal fattore tempo. La stessa Von der Leyen ha parlato di un mutamento «irreversibile» di tempi e «relazioni euroatlantiche». Ma il cambio di passo richiede anche tempi rapidi, che non sempre di coniugano con quelli degli iter di approvazione europei. «Occorrono tempo e collaborazione anche con entità esistenti come la NATO, per lavorare ad una complementarietà più che a una sostituzione di quanto già c’è – osserva Cont – Non è un’operazione semplice né attuabile overnight», dunque a brevissimo termine. «Per fortuna la stessa EDA negli ultimi anni ha iniziato a muoversi in maniera più strutturata, insieme ad altre istituzioni europee. Per esempio, si sono avviati processi per facilitare l’armonizzazione delle pianificazioni nazionali, in modo che i finanziamenti dei singoli Stati in tema di difesa siano dettati da priorità e obiettivi comuni, sviluppando percorsi che richiedono tempo e contatti continui – spiega il Direttore – Per facilitare questi percorsi si sono sviluppati strumenti come l’European Defence Fund (EDF) allo scopo di individuare risorse comuni europee per programmi di ricerca e sviluppo; o l’Act in Support of Ammunition Production (ASAP), per facilitare le aggregazioni negli acquisti di prodotti in un ambito di economia su larga scala; o ancora l’European Defence Industry Programme (EDIP) e l’European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act (EDIRPA) che hanno obiettivi analoghi.
Il gap da recuperare, però, non è marginale e oggi occorre accelerare. Ciò non significa pensare esclusivamente a un possibile “esercito comune”: «Bisogna distinguere tra due linee di azione comuni: una riguarda ciò che si può fare nel breve termine, l’altra invece attiene alle azioni di lungo periodo. Nel primo caso è possibile intervenire su programmi già sviluppati o che richiedono piccoli adeguamenti, per esempio se è sufficiente un rimpiazzo di scorte o un incremento, che possono avvenire aumentando la produzione industriale nel campo della difesa. Nel secondo caso, però, cioè se si parla di un settore che magari finora non è stato sviluppato, il lavoro da fare è molto maggiore e richiede anche tempistiche più ampie».
Ma quali sono ad oggi le priorità della difesa europea, cosa manca maggiormente? «Sicuramente più che pensare a un esercito sul campo, a prescindere dai numeri e dalla sua composizione, ci sono segmenti di difesa aerea e missilistica integrata che vanno implementati: l’Europa ha strutture e strumenti per gestire attività a bassa e media quota, ma ad alta quota siamo carenti o del tutto privi di autonomia rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti. È necessario trovare soluzioni comuni ad alcune esigenze che da soli non siamo in grado di soddisfare, perché sono troppo grandi anche per il più grande degli Stati europei. Sono capacità indispensabili in qualunque tipo di scenario e situazione, che però hanno un costo elevato. Per esempio, un programma di difesa aerea missilistica integrata non richiede solo missili e radar moderni, ma sistemi di sorveglianza, monitoraggio, ecc., che necessitano di un posizionamento spaziale, di satelliti nello spazio e a livello terrestre. Tutto ciò ad oggi è patrimonio soltanto di poche e grandi nazioni che possono permettersele. Occorrerà sedersi e discutere su come sviluppare insieme delle risposte adeguate, ad esempio anche per arrivare a una efficace protezione cibernetica a livello complessivo europeo, non solo su scala nazionale».
In realtà i sistemi di difesa aerea e missilistica integrata sono solo uno dei molti ambiti su cui gli Stati membri dell’UE devono lavorare. «A tal proposito, l’EDA ha coinvolto diversi Stati membri, tra cui l’Italia, su questo tema e altre aree critiche tramite una lettera di intenti firmata a novembre 2024. Le lettere d’intenti siglate hanno aperto la strada a opportunità collaborative a breve e lungo termine, tra cui sistemi di difesa aerea e missilistica integrata, munizioni circuitanti, guerra elettronica e una nuova classe di navi da combattimento europee (European Combat Vessels) », spiega ancora Cont.
Infine, un ultimo livello, ma non di poco conto, è rappresentato dal livello politico: «Si tratta di affrontare nuove sfide rispetto al passato – conclude Cont – Una struttura politico-decisionale è oggi necessaria, proprio come accade nella NATO. Non occorre duplicare la parte operativa, ma andare oltre l’attuale situazione di una serie di Nazioni, che hanno certamente bisogno di una struttura decisionale comune di massimo livello».