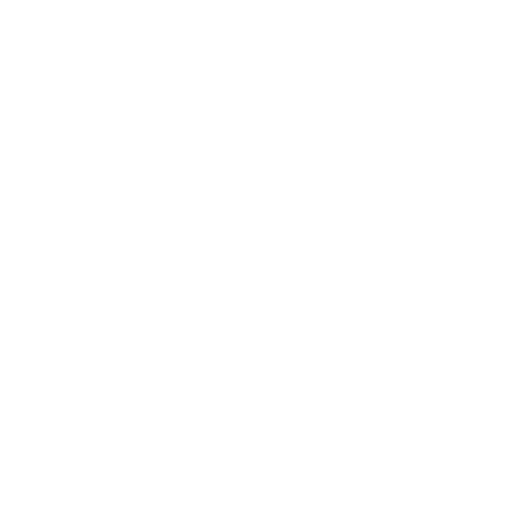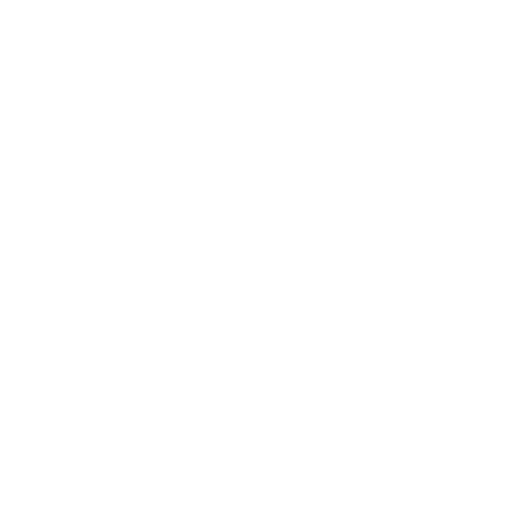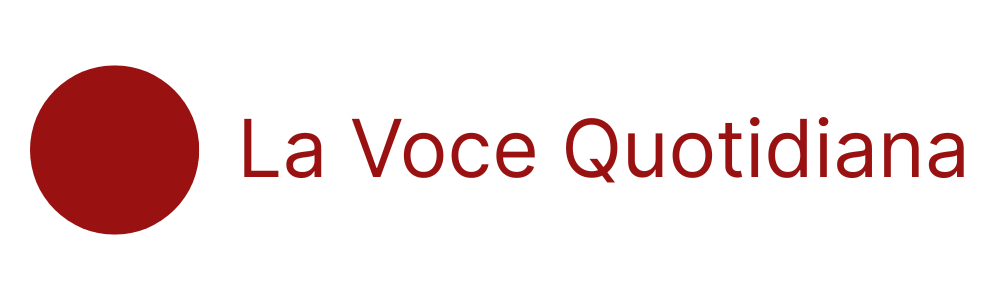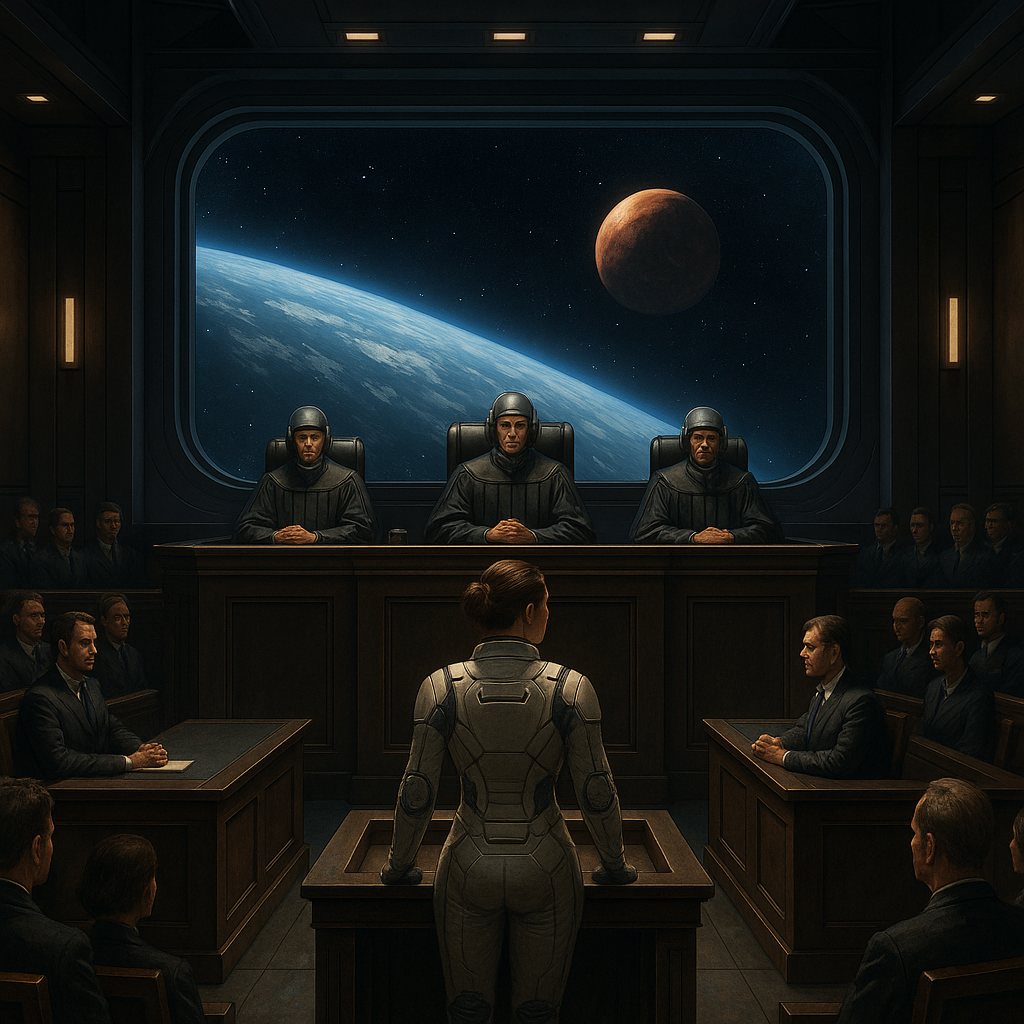Lo spazio come specchio delle contraddizioni terrestri
Sarà per la distanza, o per l’inconcepibilità di ciò che contiene, ma siamo sempre stati portati a considerare lo spazio, in qualche modo, come un altrove neutrale. Forse condizionati dalla fantascienza, forse ispirati dalla produzione cinematografica, involontariamente siamo stati indotti, non di rado, a concepirlo come un vuoto silenzioso in attesa di essere colonizzato. È invece importante, oggi più che mai, considerarlo come un’estensione strategica e simbolica della Terra. Come ogni territorio che è stato convertito in frontiera, lo spazio è destinato a riflettere, in forma amplificata, le visioni, le ambizioni e le tensioni che abitano le società umane e la loro storia. Va concepito come un laboratorio geopolitico, un campo di proiezione della competizione tecnologica, un teatro culturale e – potenzialmente – un nuovo banco di prova per mostrare e testare la nostra capacità di pensare e agire collettivamente.
L’accelerazione delle attività spaziali negli ultimi due decenni – la riattivazione dell’interesse per le missioni lunari, la proliferazione incontrollata dei satelliti privati, l’ipotesi realistica di miniere extra-lunari e colonie su Marte – non deve essere intesa soltanto come una corsa all’innovazione. È invece da leggere, più profondamente, come l’espressione di una volontà di un nuovo ordine. Ordine sul mondo, sul tempo, sugli orizzonti del possibile. Lo spazio serve – come, da sempre, la ridefinizione della concezione dello spazio cosmico – per interrogare e ripensare la posizione dell’uomo nella storia. Serve a chi ha l’ambizione di mostrarsi in grado di guidare, a chi intende trovare nuove forme per sopravvivere, a chi vuole acquisire una rinnovata capacità di narrare il futuro.
Eppure, nella fascinazione innegabile per l’infinito – un infinito che evolve, che si muove, che vibra – rischiamo di rimuovere una questione essenziale: ogni espansione spaziale rappresenta anche, inevitabilmente, un trauma epistemico. Quando i confini si allargano, i riferimenti si spezzano. Non esiste alcuna rivoluzione cosmologica che non abbia prodotto disordini culturali, religiosi, politici. Lo spazio – come ci ha insegnato la storia – non si conquista mai solamente con tecnologia e algoritmi, ma con idee, con visioni. Soprattutto, si conquista con l’accettazione di una linea di rottura.
Guardare oggi ad una nuova apertura verso lo spazio significa allora misurarsi non solo con una dimensione di ignoto esterno, ma con le prospettive intrinseche e con le tensioni interne delle nostre civiltà. Ciò che, in un modo o nell’altro, portiamo nello spazio – leggi, simboli, mercati, conflitti – è lo specchio di ciò che siamo. Ma potrebbe anche essere, potenzialmente, l’occasione per diventare altro.
Dalla diplomazia alla geopolitica: l’ordine cosmico tra le potenze
Lo spazio sembrava poter prendere forma, idealmente, come terreno di cooperazione. Dopo i traumi delle Guerre Mondiali, le prime missioni spaziali furono raccontate e in parte concepite come il simbolo della capacità dell’umanità di elevarsi oltre i propri conflitti, apparentemente al di fuori delle proprie pulsioni di dominio territoriale. Il Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico del 1967 ne sanciva la vocazione fondamentalmente pacifica: nessuna sovranità, nessuna arma, nessun possesso. Tuttavia, oggi, quella visione si è incrinata. Non è scomparsa, ma è certamente sotto pressione, stretta tra nuovi attori e strattonata da nuove logiche di potenza, che fanno dello spazio un’estensione funzionale della competizione geopolitica terrestre.
La moltiplicazione delle agenzie spaziali nazionali o continentali – tra cui Cina, India, Turchia, Corea del Sud, Unione Africana – e l’ingresso massiccio di attori privati hanno radicalmente alterato gli equilibri preesistenti e i tempi di trasformazione. La corsa non è più soltanto tra Stati, ma tra ecosistemi tecnologici, regimi normativi e visioni strategiche. La governance internazionale, così come la responsabilità equilibrante della diplomazia, fatica a reggere. Le regole sono frammentarie, le giurisdizioni appaiono incerte, le rivalità sottotraccia sembrano sempre più evidenti.
In questo vuoto normativo, pur in un tendenziale silenzio mediatico e del dibattito politico, si inserisce una dinamica particolarmente delicata: la progressiva militarizzazione dello spazio. Lo vediamo nella diffusione di satelliti per il targeting di missili ipersonici, nella creazione di reti di comando e controllo orbitali, nello svolgimento di esercitazioni anti-satellite, nell’integrazione di strutture di difesa spaziale nei centri strategici nazionali. Le armi non sono (ancora) nello spazio, ma lo spazio è sicuramente già parte del dispositivo bellico. Le dottrine della sicurezza nazionale si stanno progressivamente adattando a un mondo in cui la superiorità orbitale, per quanto oggi analizzata prevalentemente con modelli simulativi, può determinare l’esito di conflitti terrestri. Ciò che poco più di cinquant’anni fa era considerato inaccettabile sta progressivamente diventando normale.
Nayef Al-Rodhan, a capo dell’Outer Space Security Cluster del Geneva Centre for Security Policy, nell’articolo Why We Must Prevent The Militarisation Of Outer Space (pubblicato su Global Policy Journal il 3 giugno 2025) afferma che siamo arrivati a una soglia storica: se non saremo in grado di costruire una governance multilaterale, fondata su interessi collettivi e responsabilità condivise, rischieremo di trasformare lo spazio in una nuova zona opaca di conflitto. Né completamente regolata, né del tutto anarchica. Uno spazio conteso, armato, apparentemente invisibile, scarsamente monitorabile, e dunque, potenzialmente, ancora più pericoloso.
La posta in gioco, quindi, non è più soltanto il controllo delle risorse spaziali, o la leadership scientifica e tecnologica. È il tipo di ordine che vogliamo immaginare per il futuro e proiettare oltre l’atmosfera. E con esso, l’idea stessa di civiltà che intendiamo promuovere, difendere o contribuire a costruire.
Ogni nuova frontiera è una frattura
Ogni espansione del mondo conosciuto, da sempre, produce uno squilibrio. Non solo nei sistemi politici o nei meccanismi economici, ma nelle categorie mentali con cui gli esseri umani percepiscono e organizzano la realtà. La scoperta di nuovi mondi non si limita ad ampliare l’orizzonte, ma lo destabilizza. Quando Cristoforo Colombo attraversa l’Atlantico, demolendo l’immaginario delle colonne di Ercole, l’Europa non scopre soltanto nuove terre. Scopre che i riferimenti geografici, religiosi, antropologici a cui aveva fatto riferimento per secoli non bastavano più. Scopre che verità cosmologiche date per appurate erano in realtà illusorie. Si apre una crepa nella cosmologia dominante e nell’immaginario condiviso: se esistono popoli al di fuori del disegno biblico, o se il mondo è più vasto di quanto immaginato, allora la verità deve essere riscritta. La riscrittura, ovviamente, non può avvenire senza violenze.
Questo schema si ripete, ciclicamente. Ogni volta che l’umanità ha superato una nuova soglia cosmologica, ha dovuto ricostruire se stessa. Non solo la mappa, ma la mente. Non solo l’idea del mondo, ma il senso della propria presenza nel mondo. Il telescopio di Galileo rompe la corrispondenza tra cielo e divinità, tra rivelazione e accettabilità scientifica. L’evoluzionismo di Darwin rompe la continuità tra uomo e creazione. La relatività di Einstein rompe la linearità del tempo. Il primo scatto della Terra vista dalla Luna – il cosiddetto “Earthrise” – rompe l’illusione della posizione cosmica di centralità. La Terra si rivela piccola, fragile, isolata. Un punto sospeso nel vuoto. Soprattutto, un punto limitato, condiviso e – di fatto – indivisibile.
Se osserviamo la storia da questa prospettiva, questi eventi non sono semplicemente scoperte scientifiche. Sono dislocazioni culturali. Costringono le civiltà a ripensare e riconfigurare la propria posizione nel cosmo e, di conseguenza, il proprio sistema di valori, i propri codici narrativi, i propri equilibri di coesistenza. Possono produrre ansia,meccanismi di rimozione, talvolta addirittura rigetto. Tuttavia, in alcuni casi, possono aprire anche varchi per nuove forme di consapevolezza.
Lo stesso, benché in modo apparentemente diverso, accade oggi. L’accesso allo spazio profondo, l’osservazione di esopianeti potenzialmente abitabili, l’ipotesi concreta di sviluppare insediamenti lunari o marziani ci pongono di fronte a un nuovo scarto, fino a ieri impensabili. Da una parte, innegabilmente, non siamo più un’umanità confinata e vincolata alla biosfera terrestre. Non siamo, tuttavia, nemmeno pronti, culturalmente, a diventare una specie multiplanetaria. La tecnologia corre, ma le cosmologie vacillano.
È qui che antropologia e cosmologia si incontrano (e forse si devono incontrare): una osserva le culture nel tempo, l’altra il tempo delle cose nell’universo. Ma pur con prospettive diverse, entrambe ci dicono la stessa cosa: non esiste conoscenza del cosmo che non sia anche un confronto con il nostro limite. Ogni limite superato impone un nuovo inizio.
Cosmologie in competizione: lo spazio come campo epistemico
Lo spazio non è mai solamente spazio. È sempre anche un’idea, una rappresentazione, una narrazione. E, oggi più che mai, le narrazioni contano. Determinano come vengono scritte le regole, come vengono immaginate le trasformazioni, chi ha diritto di parola e chi rappresenta un elemento di instabilità. Definiscono quali scelte sembrano naturali e quali impensabili.
Per lungo tempo, almeno negli ambienti mediatici e scientifici di maggiore diffusione, la cosmologia dominante è stata quella prodotta dall’Occidente: uno spazio vuoto, geometrico, misurabile, ma allo stesso tempo una frontiera tecnica da esplorare, mappare e sfruttare. È la stessa logica che, da sempre, ha retto le grandi espansioni coloniali: ciò che non è ancora occupato (o non in maniera convenzionale) può diventare proprietà, ciò che è “vuoto” si converte immediatamente in uno spazio disponibile, ciò che è silenzioso è in attesa di essere interpretato da qualcun altro. Questa visione, un episodio alla volta, una metafora alla volta, ha condizionato i programmi spaziali, ha influenzato i trattati, ha perfino plasmato il linguaggio delle missioni. “Colonizzare Marte”, “conquistare la Luna”, “estrarre risorse dagli asteroidi”: vediamo facilmente come si tratti, tendenzialmente, di metafore di appropriazione.
Tuttavia, se riusciamo ad uscire dalla narrazione mainstream, ci renderemo conto che questa non è l’unica cosmologia possibile.
Molte culture, soprattutto indigene e di rinascita culturale in contesti post-coloniali, hanno sviluppato nel tempo visioni radicalmente diverse dello spazio. Non come un vuoto da riempire, ma come un ambiente relazionale. Non come un dominio da esercitare, ma come un equilibrio da tessere e mantenere. Il cielo, ad esempio, per molte cosmologie africane è una membrana viva, attraversata da spiriti e storie. Per alcune culture aborigene australiane, le stelle sono tracce degli antenati e strumenti di orientamento rituale e pratico. In queste prospettive esistenziali, l’universo non è separato dalla Terra, ma ne esprime la continuità.
Per quanto abituati alla rigidità di certi modelli culturali e di certe categorie narrative, è importante capire come queste cosmologie non possano essere liquidate, come spesso succede, semplicemente come folklore. Sono sistemi complessi di sapere, basati sull’osservazione, su metodologie diverse di ricerca scientifica, sull’interconnessione e sulla coabitazione. Ignorarle significa non solo rischiare di perpetuare una disuguaglianza epistemica, ma impoverire la nostra capacità – strategicamente fondamentale – di immaginare alternative.
La governance dello spazio, oggi più che mai, si deve giocare anche su questo piano. Chi decide cosa conta davvero come “conoscenza”? Chi ha il potere di definire gli immaginari attraverso i quali plasmeremo il futuro? Chi avrà la responsabilità di scegliere il linguaggio che utilizzeremo non solo per rappresentare, ma per gestire le nuove sfide cosmologiche? Se lo spazio resta un dominio costruito esclusivamente sulla base della razionalità tecnico-occidentale, tutto ciò che eccede quel paradigma verrà escluso o trascurato: culture, voci, linguaggi, diritti. Ma anche possibilità di futuro.
Proprio in questo momento storico, proprio la pluralità delle cosmologie potrebbe invece diventare una risorsa strategica. Non solo per costruire un’etica spaziale più inclusiva e adattiva alla complessità della società globale, ma per ripensare i fondamenti stessi della cooperazione internazionale, fuori dalla gerarchizzazione delle legittimità culturali, fuori dalle logiche indirette di dominio. In un sistema globale sempre più interdipendente – e sempre più geopoliticamente fragile – l’ascolto di altre visioni del cosmo potrebbe essere ciò che ci salva da noi stessi. Ciò che ci mette in guardia dal rischio di non considerare opzioni al di fuori della nostra ordinaria consuetudine epistemica.
Un nuovo contratto cosmico: dallo sfruttamento alla custodia
Occorre tuttavia riconoscere un problema culturale profondo, pervasivo, non trascurabile: lo spazio sta entrando a pieno titolo nella logica del capitalismo egemonico ed estrattivo. Non è più soltanto un laboratorio di scienza, o di immaginazione, ma una vera e propria infrastruttura strategica, integrata nelle economie digitali, nei piani di sicurezza energetica, nei modelli di crescita. Le orbite basse si stanno popolando di satelliti (per ora) commerciali, le compagnie minerarie studiano le condizioni per estrarre platino dagli asteroidi, gli investimenti per progetti di colonizzazione lunare e serre interplanetarie si stanno moltiplicando. L’orizzonte sembra quindi chiaro: rendere lo spazio un’estensione funzionale delle catene del valore e del dominio terrestri.
Tuttavia, al di là del tecnoentusiasmo, questa prospettiva ci deve porre di fronte ad una domanda fondamentale, dal punto di vista strategico ed esistenziale: che tipo di civiltà vogliamo esportare nello spazio?
La lezione del pianeta Terra sembra chiara: la logica dell’estrazione senza limiti ha generato squilibri ecologici probabilmente irreversibili, ha alimentato processi di concentrazione del potere, ha prodotto diseguaglianze sistemiche. Non siamo ancora riusciti a risolvere le fratture del mondo che abitiamo – fratture che noi abbiamo provocato – e già ci proiettiamo verso altri mondi, con gli stessi strumenti concettuali, con le stesse visioni politiche, con le stesse proiezioni economiche. Non c’è nulla di inevitabile in questo, ma certamente c’è molto di culturale.
In alternativa, alcune voci iniziano a proporre una diversa grammatica politica: quella della custodia. Non una rinuncia all’azione o alla tecnologia, ma un’etica della presenza. L’astrofisica e divulgatrice indigena australiana Karlie Alinta Noon, in un recente report pubblicato dal Centre for International Governance Innovation (Indigenous Cosmic Caretaking and the Future of Space Exploration, CIGI Paper 305, 2024) introduce il concetto di “caretaking cosmico”, una visione in cui propone di far coincidere l’esplorazione non con la dominazione, ma con la responsabilità di usare la scoperta come un processo di apertura, anziché come un processo di isolamento. Responsabilità di conoscere senza distruggere, di mappare senza possedere, di osservare e catalogare senza mercificare.
Questo paradigma si basa su un principio semplice, ispirato da una delle cosmologie ancestrali di cui abbiamo parlato: lo spazio non è una risorsa, ma uno spazio di relazione. E come ogni relazione va costantemente negoziata, riscoperta, rispettata, protetta. Significa quindi andare ben oltre il Trattato del 1967, pensando a regole condivise per la gestione degli ambienti lunari e marziani, stabilendo limiti all’uso commerciale delle orbite, impedendo la privatizzazione unilaterale delle infrastrutture critiche. Soprattutto significa, in modo ben più profondo, imparare a cambiare sguardo: concepire l’evoluzione tecnologica non come un mezzo di dominio, ma come uno strumento di coabitazione.
Tale cambiamento, evidentemente, richiederebbe istituzioni nuove. Né la frammentazione giuridica attuale, né le coalizioni ad hoc tra potenze sembrano, in un momento globalmente così fragile, permettere di sostenere una governance spaziale all’altezza delle sfide future. Servono modelli cooperativi multilivello, capaci di integrare Stati, attori privati, comunità epistemiche e rappresentanze culturali. Serve, in altre parole, un nuovo contratto cosmico.
Un patto che non si limiti a definire equilibri di esercizio del potere, a distribuire risorse o a prevenire conflitti, ma che risponda a una domanda più radicale: cosa vogliamo che significhi, oggi, essere umani, nell’universo?
Interrogare l’ignoto per ripensare l’umano
Come abbiamo visto, non possiamo più pensare lo spazio semplicemente come un’estensione neutra del nostro mondo. Dovremmo, piuttosto, imparare a concepirlo e ad utilizzarlo come uno specchio deformante, che amplifica la nostra natura, i nostri desideri, le nostre paure, le nostre debolezze. Proprio per questo, affrontato con la giusta profondità, lo spazio rappresenta quindi anche un’opportunità: quella di osservare da fuori, con la distanza di una simulazione al di fuori dei nostri schemi usuali, ciò che di solito viviamo da dentro. Le nostre dinamiche politiche, le nostre narrazioni, le nostre contraddizioni.
La più grande posta in gioco, oggi, non è quindi la conquista di Marte. È la possibilità di immaginare un ordine diverso, in cui il potere non coincida con il possesso, in cui la conoscenza non sia il preludio allo sfruttamento, in cui la pluralità delle visioni non venga percepita come ostacolo, ma come risorsa. Un ordine in cui l’umano non venga più pensato come misura assoluta dell’universo, ma come parte – cosciente, vulnerabile, responsabile – di un sistema più grande. Abbiamo bisogno di un nuovo tipo di lucidità, che ci permetta di tenere insieme, in maniera strutturale, la competenza strategica e la consapevolezza simbolica.
Esplorare lo spazio, oggi, significa anche esplorare i limiti della nostra civiltà e della storia che ne ha determinato la forma. E forse, oggi più che mai, imparare a riconoscere che ciò che non conosciamo – ciò che non possiamo prevedere né controllare – non deve essere percepito come un problema da risolvere, ma come una condizione da abitare.
Il futuro non ha bisogno di nuovi colonizzatori, ma di custodi, di mediatori, di visionari che sappiano stare dentro l’ignoto senza volerlo ridurre, senza volerlo ricondurre ai limiti della cognizione umana contestuale, inevitabilmente depauperante. Forse è proprio questo il senso più radicale della sfida spaziale: non portarci oltre i confini della Terra, ma portarci a scoprire come andare oltre noi stessi. Forse, più che nuovi orizzonti, ci servono nuovi sguardi.